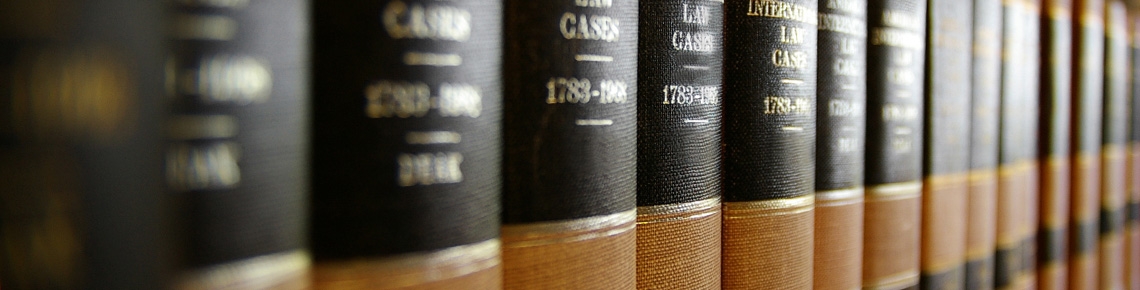Successione digitale: di che cosa si tratta?

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio trattare con voi un argomento davvero interessante e particolare. Quando parliamo di eredità siamo soliti pensare che la stessa riguardi esclusivamente i nostri beni materiali.
Al giorno d’oggi, però, ciascun individuo possiede non solo case, auto e vestiti ma anche un vero e proprio patrimonio digitale che comprende diversi beni come foto, video, documenti conservati in cloud, profili social, caselle di posta elettronica, chat, siti web, contenuti multimediali, wallet, portafogli digitali e criptovalute che, per la loro intangibilità e per il fatto di essere spesso protetti da password, rischiano di venire letteralmente dimenticati.
Si tratta, infatti, di un patrimonio spesso sottovalutato, ma che può avere valore economico, affettivo o legale.
Viene dunque spontaneo chiedersi cosa succede a tutti questi dati quando una persona muore? Chi può accedervi? E in base a quali regole?
Tutte queste domande rientrano nella disciplina della cd. “successione digitale”, termine con cui si sta ad indicare il trasferimento o la gestione del patrimonio digitale di una persona nel momento in cui questa viene a mancare.
Ma cosa dice la legge al riguardo?
Dal momento che la legge italiana ancora non prevede una disciplina ad hoc della successione digitale, il tema è a dir poco complesso in quanto le disposizioni vigenti in materia di successione ereditaria poco si addicono a beni immateriali, spesso non monetizzati.
Attenzione però!
Il fatto che il nostro ordinamento non sancisce quale destino debba avere il patrimonio digitale di una persona, non significa che i beni che ne fanno parte non possono essere tutelati.
L’art. 2 terdecies del D. Lgs. 196/2003 afferma che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – inerenti al diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione e al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione – riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Non solo.
Anche le singole piattaforme digitali, così come ciascun social network, si sono attivate per garantire ai propri utenti di poter gestire il proprio patrimonio digitale anche in prospettiva futura.
Ad esempio, Google prevede la funzione “gestione account inattivo” che permette all’utente di designare un soggetto affinché riceva determinati dati dell’account in caso di sua morte o inattività.
Apple consente invece di aggiungere “contatti erede” al proprio account: si tratta di persone di fiducia che, in caso di morte dell’utente, potranno accedere ai dati archiviati nell’account Apple dello stesso.
Facebook, infine, permette di trasformare un profilo in un “account commemorativo” o di richiederne l’eliminazione, anche designando un contatto erede che gestisce il profilo dopo che è stato reso commemorativo.
Nonostante ciò, è evidente che la mancanza di una disciplina puntuale rende tutto più difficile, al punto tale che, in alcuni casi, per poter accedere ai dati digitali di un caro defunto è necessario un ordine del giudice e, quando i dati sono criptati o archiviati su server esteri, può diventare impossibile recuperarli.
In un mondo digitale in continua evoluzione e in cui i social network e i contenuti multimediali sono diventati per molti un vero e proprio lavoro, è impensabile che il patrimonio digitale non sia riconosciuto e disciplinato in quanto tale.
In attesa che il vuoto normativo venga colmato, non ci resta che disporre in prima persona del nostro patrimonio digitale, per garantire che lo stesso venga tutelato anche nell’avvenire.